 Stamattina come quasi tutte le mattine per lavoro prendo la metro. Non c'è nemmeno bisogno di chiamarla "metropolitana" a Milano: è "la metro", per tutti.
Stamattina come quasi tutte le mattine per lavoro prendo la metro. Non c'è nemmeno bisogno di chiamarla "metropolitana" a Milano: è "la metro", per tutti.Dopo poco mi si siede di fianco un tipo: corporatura media, camicia rossa, jeans ipergriffati, capello laccato e carnagione abbastanza abbronzata. Italiano, avrei detto, probabilmente del sud Italia appoggiandomi agli stereotipi comuni: sopracciglia scure, baffi sottili e pizzetto, capelli neri, e lineamenti marcati ma non troppo. Si appoggia allo schienale e si distende, gambe aperte, braccia allargate, masticando qualcosa in bocca con fare nervoso.
Mi accorgo che la gente davanti e di fianco a lui comincia a guardarlo, in modo strano: occhiate furtive e subito l'abbassarsi degli occhi, quasi ad aver paura di esser colti sul fatto, posture cambiate velocemente con fare nervoso, occhi che indugiano sulle braccia tatuate quasi a cercare qualcosa che si sa, ci deve essere, ma è coperto astutamente.
 "Buchi?", mi chiedo, senza sapere perchè. "Forse questa gente sa qualcosa che io non so, forse l'ha già visto, forse è un habituè della stazione e in parecchi l'hanno visto fare qualcosa di scomodo". Comincio a scrutarlo, piano anch'io. Qualcosa ci deve essere.
"Buchi?", mi chiedo, senza sapere perchè. "Forse questa gente sa qualcosa che io non so, forse l'ha già visto, forse è un habituè della stazione e in parecchi l'hanno visto fare qualcosa di scomodo". Comincio a scrutarlo, piano anch'io. Qualcosa ci deve essere. Scendo io, lui no. E fatti due passi mi accorgo di una cosa, semplice ed importante allo stesso tempo. Lo guardavo per chiedermi chi fosse, ma non mi sono chiesto perchè. Perchè lo guardavano tutti, perchè se tutti facevano così DOVEVA ESSERCI PER FORZA UN MOTIVO, e il motivo doveva essere anche giusto. Non buono o sensato, semplicemente giusto.
Scendo io, lui no. E fatti due passi mi accorgo di una cosa, semplice ed importante allo stesso tempo. Lo guardavo per chiedermi chi fosse, ma non mi sono chiesto perchè. Perchè lo guardavano tutti, perchè se tutti facevano così DOVEVA ESSERCI PER FORZA UN MOTIVO, e il motivo doveva essere anche giusto. Non buono o sensato, semplicemente giusto. Credevo di essere diverso dagli altri: io giornalista, attento ai dettagli, sempre lì a ricordare che per ogni cosa c'è un perchè ed un motivo, che possiamo considerare insensato o meno ma che comunque esiste. Io, che prima di raccontare una storia cerco sempre di coglierne tutti i punti di vista e liberarmi dai pregiudizi, per scoprire l'ombra nel mezzo delle versioni di tutti, là dove si annida la verità. Io che guardo, ascolto, racconto, intervisto, dipingo e scrivo in punta di penna, cercando i fatti e non le versioni.
Credevo di essere diverso dagli altri: io giornalista, attento ai dettagli, sempre lì a ricordare che per ogni cosa c'è un perchè ed un motivo, che possiamo considerare insensato o meno ma che comunque esiste. Io, che prima di raccontare una storia cerco sempre di coglierne tutti i punti di vista e liberarmi dai pregiudizi, per scoprire l'ombra nel mezzo delle versioni di tutti, là dove si annida la verità. Io che guardo, ascolto, racconto, intervisto, dipingo e scrivo in punta di penna, cercando i fatti e non le versioni.Credevo di essere diverso.
Ma sono caduto anch'io, alla prima distrazione, nella trappola del luogo comune.












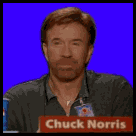

Nessun commento:
Posta un commento